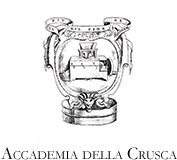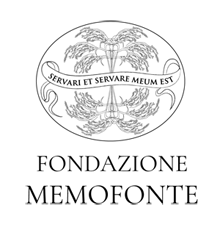Lista dei contesti relativa alla forma scelta
dall'
| cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall' alito esplosivo un automobile ruggente che sembra | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| piroscafi avventurosi che fiutano l' orizzonte le locomotive dall' ampio petto che scalpitano sulle rotaie come enormi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sembra applaudire come una folla entusiasta è dall' italia che noi lanciamo pel mondo questo nostro | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| grandezza morfinizzato da una vigliaccheria stomachevole ed avvilito dall' abitudine dei suoi piccoli commerci loschi noi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| furono lanciati dai poeti e dai pittori futuristi dall' alto della torre dell' orologio sulla folla che | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che mangiamo sempre alla carlona coll' epigastro strangolato dall' amore o dell' arrivismo così si svolge | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| religione fanatica incosciente e snobistica del passato alimentata dall' esistenza nefasta dei musei ci ribelliamo alla | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| come i nostri antenati trassero materia d' arte dall' atmosfera religiosa che incombeva sulle anime loro così | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| primitivi di una nuova sensibilità completamente trasformata fuori dall' atmosfera in cui viviamo noi non sono che | ||
Umberto Boccioni; Carlo Dalmazzo Carrà; Luigi Russolo; Gino Severini; Giacomo Balla (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| critici fatalmente venali e ignoranti liberando il pubblico dall' influenza malefica dei loro scritti fondare a | ||
Balilla Pratella, Francesco (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sintesi dell' armonia simile alla linea ideale formata dall' incessante fiorire di mille onde marine dalle creste | ||
Balilla Pretella (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| perché nostra e da noi proveniente sarà circonfusa dall' orchestra atmosfera sonora piena di tutte le voci | ||
Balilla Pretella (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i nuovi atteggiamenti della natura sempre diversamente domata dall' uomo per virtù delle incessanti scoperte scientifiche | ||
Balilla Pretella (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| marine e aeree e dominata dal vapore e dall' elettricità bisogna introdurre nel teatro la sensazione | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| luce che splende oltre le cime inaccessibili dall' alto dello zenit ho contemplato in sogno le | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| avvelenatrici spiavano il vostro passaggio mille morbide primavere dall' ali di vampiro vi assopirono voluttuosamente subito | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| patria d' esercito potente e di guerra possibile dall' idea di monarchia reazionaria e clericale 5 | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e dei fabbricanti di falsi capolavori guardatevi dall' attirare sulla spagna le grottesche carovane dei ricconi | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gran binario futurista ci coricammo tutti fasciati dall' immensa follia della via lattea all' ombra del | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
a queste parole il sole ci porse dall' estremità dell' orizzonte il suo tremulo e rosso | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sibilante e gli urli delle acque talvolta dall' alto delle colline guardavamo l' oceano gonfiare progressivamente | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gettando di sella le torri illustri vecchi cavalieri dall' armatura sonora crollati giù dagli arcioni marmorei dei | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mai tentato prima di noi ben lontani dall' appoggiarci sull' esempio dei greci e degli antichi | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| leggi completamente nuove che possano liberare la pittura dall' ondeggiante incertezza nella quale si trascina la | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| un nudo qualunque traendo il significato del quadro dall' oggetto che il modello tiene in mano o | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| esempi dipingendo una persona al balcone vista dall' interno noi non limitiamo la scena a ciò | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vedere come gli fu insegnato con occhi falsati dall' abitudine noi andiamo distruggendo ogni giorno in | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mentre sosteneva l' assedio della sua città vedendo dall' alto delle mura il nemico minacciare la vita | ||
Valentine de Saint-Point (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| orientali ammasso informe di influenze che vanno dall' eccesso di particolari astrusi dell' asia alla infantile | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| spirituale più vasta che gli permette di andare dall' impressionismo del balzac all' incertezza dei borghesi | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nelle linee muscolari di un corpo così dall' ascella di un meccanico potrà uscire la ruota | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di quella che ci fa temere di uscire dall' arte che esercitiamo non v' è né | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| materia essa si rivelò al mio spirito dall' alto di un aeroplano guardando gli oggetti | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| uomo meccanico dalle parti cambiabili noi lo libereremo dall' idea della morte e quindi dalla morte stessa | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di piccola danza borghese viene distrutta e sostituita dall' intuizione libera di relazioni ritmiche istintive e simpatiche | ||
Balilla Pratella, Francesco (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| modo staccato dal corpo e divenuto aereo guarda dall' alto con una terribile lucidità le frasi inattese | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| imprevisti bisogna sceglier sapientemente bisogna - guidati dall' intuizione e dalla volontà -valutare le sensibilità e | ||
de Saint-Point, Valentine (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| carne da una carne sana forte purificata dall' amplesso lo spirito balza lucido e chiaro | ||
de Saint-Point, Valentine (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l' accordo suono complesso si manifestarono gradatamente passando dall' accordo perfetto assonante e con poche dissonanze di | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| maggiore libertà e facilità erotica nella donna e dall' esagerazione universale del lusso femminile mi spiego | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| incitare i giovani futuristi a liberare il lirismo dall' atmosfera solenne piena di compunzione e d' incensi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| copia in arte delle sintassi già condannate dall' uso in tutte le lingue dell' aggettivo | ||
Guillaume Apollinaire (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| signac e seurat noi constatiamo che ben lungi dall' intuire il problema e dall' affrontare le difficoltà | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che ben lungi dall' intuire il problema e dall' affrontare le difficoltà del suono e del rumore | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l' arabesco dinamico come l' unica realtà creata dall' artista nel fondo della sua sensibilità 5 | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le ipotesi appassionate e tutti i dominii esplorati dall' ultra-microscopia mi spiego non già come documento | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sistematicamente ciò che viene dal nostro passato o dall' estero e negano con gioia il genio creatore che | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| 1 il teatro di varietà nato con noi dall' elettricità non ha fortunatamente tradizione alcuna né maestri | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| eseguire una sinfonia di beethoven a rovescio cominciando dall' ultima nota ridurre tutto shakespeare ad un | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| serietà in tal caso ci viene dalla ammirazione dall' invidia dalla vanità quello che ci dice | ||
Palazzeschi, Aldo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dolore cosciente lue passatista aggravata dal romanticismo cronico dall' affettività mostruosa e dal sentimentalismo pietoso che deprimono | ||
Palazzeschi, Aldo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| temere dal passato ammuffito tutto dovete sperare dall' avvenire abbiate fiducia nel progresso che ha | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le parole critico e critica sono ormai disonorate dall' uso immondo che se ne è fatto noi | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sono numerosi essi gli sono stati imposti dall' ambiente in cui s' è formato il | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
- la combinazione di elementi tratti dall' esperienza più o meno dissimili è la materia prima | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| espressa in formule della quantità di energia cerebrale rappresentata dall' opera stessa indipendentemente dalle impressioni buone cattive o | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| indipendentemente dalle impressioni buone cattive o nulle che dall' opera possa ricevere la gente tutto ciò | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quale indichi la quantità di energia artistica rappresentata dall' opera e la più o meno grande quotazione | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| da un lato darà all' artista diritti inoppugnabili dall' altro dovrà imporgli doveri e responsabilità precise | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| laconismo e la simultaneità che derivano dal turismo dall' affarismo e dal giornalismo la passione per il | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| velocità della nave le distanze dei tiri fissate dall' alto del cassero nella ventilazione fresca delle probabilità | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| probabilità guerresche la vitalità strana degli ordini trasmessi dall' ammiraglio e subitamente divenuti autonomi non più umani | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di un rimorchiatore sulla mosa ed è seguita dall' onomatopea velata ffiiiii fiiiiiii eco dell' altra riva | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| orecchio al medesimo suono di campana esco dall' impreciso dal banale e m' impadronisco della realtà | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quotidiano dei bisogni imposti dalla rapidità delle comunicazioni dall' agglomeramento degli uomini dall' igiene e da cento | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dalla rapidità delle comunicazioni dall' agglomeramento degli uomini dall' igiene e da cento altri fenomeni della vita moderna | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| frequenti i mutamenti di moda e quelli determinati dall' avvicendarsi dei convincimenti religiosi e degli ordinamenti politici | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| all' architettura è un assurdo e che soltanto dall' uso e dalla disposizione originale del materiale greggio | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dell' arcaismo è stato perché bisognava liberarsi brutalmente dall' accademico e dal grazioso prima di andare più | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Christofer R.W. Nevinson (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di morte dal conservatorismo tradizionale delle accademie e dall' abituale indifferenza del pubblico sarà un alcool | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Christofer R.W. Nevinson (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vogliamo liberare la nostra razza da ogni neutralità dall' indecisione paurosa e quietista del pessimismo negatore e | ||
Balla, Giacomo (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le scarpe futuriste saranno dinamiche diverse l' una dall' altra per forma e per colore atte a | ||
Balla, Giacomo (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i campi esplorati dinamico cioè nato dall' improvvisazione dalla fulminea intuizione dall' attualità suggestionante e | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Emilio Settimelli; Bruno Corradini (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
cioè nato dall' improvvisazione dalla fulminea intuizione dall' attualità suggestionante e rivelatrice noi crediamo che | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Emilio Settimelli; Bruno Corradini (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| fu uno dei principii essenziali dei nostri manifesti futuristi dall' origine del nostro movimento cioè da 6 | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Boccioni, Umberto; Russolo, Luigi; Sant'Elia, Antonio; Sironi, Mario; Piatti, Ugo (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| terra poiché possiede un incalcolabile capitale inutilizzato costituito dall' enorme patrimonio delle opere d arte antiche ammucchiate nei | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| artistico il nostro glorioso rinascimento sarà superato dall' arte italiana di domani si obietterà anche che | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
si obietterà anche che questa vendita allontanerà dall' italia il fiume rimunerativo dei visitatori stranieri | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e tutta l' arte italiana d' oggi è caratterizzata dall' indifferenza per la tecnica così le ricerche | ||
Boccioni, Umberto (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| uomo dalla decomposizione determinata dalla lentezza dal ricordo dall' analisi dal riposo e dall' abitudine l' | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| lentezza dal ricordo dall' analisi dal riposo e dall' abitudine l' energia umana centuplicata dalla velocità | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| giri al minuto massima velocità meccanica raggiunta dall' uomo bisogna rapire agli astri il segreto | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| treni diretti il mio sguardo a spola va dall' orologio murale al piatto fumante la vite-angoscia-ricordo penetra | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la preferenza al modo di dire efficacemente lavorato dall' uso quotidiano del giornale e della piazza | ||
Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Arnaldo Ginanni-Corradini (Ginna); Remo Chiti; Emilio Settimelli; Mario Carli; Vieri Nannetti; Oscar Mara (Attilio Franchi) (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| intuizioni bisogna sentirsi penetrati ad un tempo dall' orrore della pesantezza uniforme e dalla ossessione dell' | ||
Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Arnaldo Ginanni-Corradini (Ginna); Remo Chiti; Emilio Settimelli; Mario Carli; Vieri Nannetti; Oscar Mara (Attilio Franchi) (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| non sono stati chiamati sono partiti volontari dall' isola lontana si sono davvero levati i morti | ||
Marica, Pasquale (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| un viaggiatore contempla dopo lunghe fatiche il mare dall' alto di una montagna daremo viaggiatore mare montagna | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Emilio Settimelli; Arnaldo Ginna (Ginanna-Corradini); Giacomo Balla; Remo Chiti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| poco si trasformano in donne imploranti iddio che dall' alto si compiace daremo i conventi i cuculi | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Emilio Settimelli; Arnaldo Ginna (Ginanna-Corradini); Giacomo Balla; Remo Chiti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| depero 1916 verbalizzazione astratta e derivata dall' onomatopea dal rumorismo dalla brutalità delle parole in libertà futuriste | ||
Depero, Fortunato (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
la statura dell' individuo è stata rialzata dall' idea di rappresentanza questa idea invece ha | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| migliori noi diamo un amore assoluto non confortato dall' obbrobriosa speranza dell' immortalità sogno d' anime usuraie | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inaffiare terre e fogliami elettricamente essi regolano dall' alto dei loro monoplani per mezzo di telefoni | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| danza futurista sarà dunque accompagnata da rumori organizzati e dall' orchestra degli intonarumori inventati da luigi russolo | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| degli hohenzollern e degli asburgo sempre più scosse dall' impeto rivoluzionario democratico della conflagrazione hanno sperato che | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| un metodo di vita che gli ha imposto dall' epoca e per un bisogno esistente nell' osservatore | ||
Emilio Notte; Lucio Venna (Giuseppe Landsmann) (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| accademie ultimo residuo pacifista il grido dall' arme lanciato da noi futuristi qualche anno fa | ||
Enrico Prampolini (1918) | ||
| vedi testo esteso | ||
| in appresso l' arte precipuamente visiva e plastica dall' arte acustica e tale dimostrando come letterarietà e | ||
Bragaglia, Anton Giulio (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| famiglia cattolica mediocrista soffocata da ruderi illustri fuori dall' elettoralismo miserabile di provincia e dalla taccagneria degli | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| in una parola futurista deve essere libera dall' asservimento agli stranieri per quanto lo è necessario | ||
Roberto Clerici; Michele Leskovich; Pietro Albrighi (1921) | ||
| vedi testo esteso | ||
| cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall' alito esplosivo un' automobile ruggente che sembra | ||
Enrico Prampolini; Ivo Pannaggi; Vinicio Paladini (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| suo valore interferenziale nella trasposizione della costruzione figurativa dall' artista alla tela del suo valore quasi di | ||
Vinicio Paladini (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forme erotiche dei cerebralismi e dei sentimenti generati dall' amore l' amore è una stupida limitazione dei | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vertice di un angosciato periodo di ricerche che dall' impressionismo al cubismo non trovavano uno sbocco | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i nuovi elementi di luce forma e colore importati dall' elettricità dai nuovi materiali dai mezzi di trasporto ecc | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di visioni dal basso in alto con visioni dall' alto in basso 7° le inclinazioni immobili e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Sansoni, Guglielmo (Tato) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| volge la propria ispirazione verso le forme create dall' industria moderna la lirica verso la telegrafia così la | ||
Enrico Prampolini (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a tre dimensioni alla creazione dello spazioscenico polidimensionale dall' attore umano alla nuova individualità scenica dell' attore | ||
Enrico Prampolini (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| o di abolizione del debiti finanziari ben lungi dall' essere paradossale è in realtà un provvedimento di | ||
Camuzzi, Carlo (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| indispensabile in modo tale da tenerne conto fin dall' inizio della costruzione vi sono poi tutti | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| arte il fenomeno sensoriale pittorico spinto coraggiosamente dall' assillante desiderio di scoperte nuove doveva raffinarsi talmente | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| amore intenso della natura amore provocato in parte dall' igiene e dallo sport ha condotto il progettista | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| noi futuristi sicuri di questa nostra vittoria garantita dall' ormai provata potenza creatrice della nostra razza mentre | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Enrico Prampolini; Francesco Monarchi; Mino Somenzi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| con progetti di architettura illustrativa non voluti dall' artista come normali esercitazioni decorative ma creati | ||
Renato Di Bosso (Renato Righetti) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| à necessariamente un riscontro anche in altri campi dall' edilizia ai costumi ciò non nega la | ||
Fillia (Luigi Colombo-Fillia) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la forma più alta della bellezza si sposta dall' edificio in sé alla città e ciò che | ||
Fillia (Luigi Colombo-Fillia) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| esatta l’ affermazione che sant'elia aveva espresse fin dall' anteguerra che la casa deve sembrare ad una | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mondiale la nostra razza occorreva dunque guarirla dall' eccessiva affettività e dalle nostalgie esaltando gli amori | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| architettura che difenda l' abitante dal caldo meridiano dall' umido freddo notturno dagli insetti dai puzzi mefitici | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Colombo, Luigi (Fillia); Sansoni, Guglielmo (Tato); Cocchia, Carlo (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di motori a scoppio batteria di idrovore e motoaratrici fuor dall' incubo delle abolite paludi pontine immenso prodigio geometrico | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| si sforza di essere sempre più autonomo sganciato dall' individuo umano nuovo compito della poesia e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sintetica documentaria dinamica di paesaggi e urbanismi visti dall' alto b- l' aereopittura trasfiguratrice lirica ebbra | ||
Tullio (Mazzotti) d'Albisola; Filippo Tommaso Marinetti (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l' addobbo cioè l’ abito di completamento dall' architettura al quadro dal mobile al fregio questo | ||
Depero, Fortunato (1939) | ||
| vedi testo esteso | ||
| specifico ambiente da quello privato a quello pubblico dall' osteria al caffè-ristoratore dalla stanza per il bimbo | ||
Depero, Fortunato (1939) | ||
| vedi testo esteso | ||
| decisiva l’ architettura interna polimaterica o plastica murale inventata dall' aero-pittore cosmico biochimico enrico prampolini decisiva l’ aeropoesia | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1940) | ||
| vedi testo esteso | ||
| attinie celesti queste torte di strati vaporosi divorati dall' ingordigia del sole queste anatomie muliebri che veli | ||
Tullio Crali (1940) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la sua distintissima personalità pensante astuta intrepida profetizzata dall' aviatore aeropittore futurista fedele azari che fondò venti anni | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| una naturalezza di volo e di osservazione aeropoetica dall' alto 8° un goliardismo spensierato e mondo | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| secoli a venire dalle perfezioni del rinascimento e dall' esasperazione dal barocco che intendevano aggiungere alle convenzioni | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di sovrapposto all' architettura è un assurdo soltanto dall' uso e dalla disposizione originale del materiale greggio | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| superstite sarà dominata e ossessionata dalla tecnica e dall' organizzazione mentre la civiltà meccanica giunto all' apice | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||