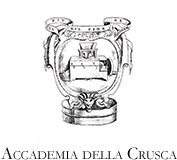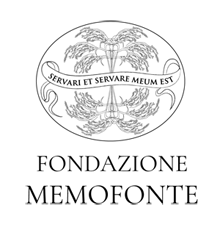Lista dei contesti relativa alla forma scelta
uso
| vecchio periodo tradizionale è appunto mediante un uso sapiente dell' aggettivo e dell' avverbio che si | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| in base alla quale era ammesso solo l' uso di pochi intervalli consonanti hanno molto limitato il | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| o meno timidamente noi futuristi iniziamo l' uso audace e continuo dell' onomatopea questo non | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| in arte delle sintassi già condannate dall' uso in tutte le lingue dell' aggettivo | ||
Guillaume Apollinaire (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| intellettuale insomma l' immaginazione senza fili le parole in libertà l' uso sistematico delle onomatopee la musica antigraziosa senza quadratura | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i colori fangosi 4 l' uso dell' orizzontale pura della verticale pura e di | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ciò non bastasse è stato per 1 uso del sistema diatonico ristretto anche nel suo sviluppo | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| verbo l’ abolizione del verbo conduce all’ uso esclusivo di sostantivi ne deriva quindi una | ||
Folgore, Luciano (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| parole critico e critica sono ormai disonorate dall' uso immondo che se ne è fatto noi futuristi | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che ci lega ai motori ci spingono all' uso dell' onomatopea il rumore essendo il risultato | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che ci lega ai motori ci spingono all’ uso dell’ onomatopea il rumore essendo il risultato | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e instabile tavolozza concessa dalle materie colorate in uso sono altrettante buone ragioni che mi hanno sempre | ||
Leonardo Dudreville (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| leggi naturali il perfezionamento dei mezzi meccanici l' uso razionale e scientifico del materiale nella vita moderna | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
il calcolo sulla resistenza dei materiali l' uso del cemento armato e del ferro escludono l' | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nuovissima sensibilità 5 - l' uso di materiali massicci voluminosi duraturi antiquati costosi | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| architettura è un assurdo e che soltanto dall' uso e dalla disposizione originale del materiale greggio o | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| preferenza al modo di dire efficacemente lavorato dall' uso quotidiano del giornale e della piazza 5 | ||
Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Arnaldo Ginanni-Corradini (Ginna); Remo Chiti; Emilio Settimelli; Mario Carli; Vieri Nannetti; Oscar Mara (Attilio Franchi) (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| una giostra cortese di eleganza e acutezze a uso delle dame dei principi e dei dotti | ||
Bruno, Antonio (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le forme già stabilite dal successo e dall’ uso sono il suo passato non cambia per | ||
Bruno, Antonio (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il fascino del corpo della donna quanto l' uso della nudità nei bordelli i gioielli e | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a favore d' industrie artistiche e ottenere l' uso di palazzi per adibirli ad abitazioni di artisti | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| rognoni b italianizzazione della nuova architettura contro l' uso sistematico di plagiare le architetture straniere cominciare | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| potranno essere semplicemente declamate e si dovrà far uso della declamazione coloristica tessuto variopinto e | ||
Benedetto, Enzo (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che esso apporta alle possibilità pittoriche specialmente come uso di materiali un soggetto che appassioni il | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| piacere tattile prelabiale 5 l’ uso dell’ arte dei profumi per favorire la degustazione | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tavola mediante ventilatori 6 l’ uso della musica limitato negli intervalli tra vivanda e | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| politica a tavola 8 l’ uso dosato della poesia e della musica come ingredienti | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e nel vuoto autoclavi centrifughe dializzatori l’ uso di questi apparecchi dovrà essere scientifico evitando p | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| geometrico dell’ estetica della macchina indispensabile rinnovamento l’ uso della luce elettrica per decorare le chiese col suo | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a loro disposizione per influenzare italianamente il mondo uso della lingua italiana negli avvisi nelle insegne e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| del vetro del legno ecc esiste l' uso dei materiali nuovi la di cui esperienza permette oggi | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| grande affidamento di resistenza e il suo uso è in questi casi anche un' economia perchè | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sta appunto studiando la possibilità di un largo uso della latta anche in rapporto alla architettura | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| c’ insegna che ben lungi dallo sparire l’ uso dell’ arma bianca vi si é sviluppato parallelamente | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
e quasi impossibile stabilire mediante statistiche l’ uso e l’ efficacia dell’ arma bianca poiché le | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la sua fisonomia la sua estetica l’ uso delle travature di ferro pieno con le sue | ||
Cesare Augusto Poggi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| partenone è per voi il sontuoso radiatore fuori uso della grecia di questa agile e possente automobile | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mal intesa igiene molti giovani italiani adottarono l' uso americano e teutonico della testa nuda la | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Enrico Prampolini; Francesco Monarchi; Mino Somenzi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| del cappello 1 condanniamo l' uso nordico del nero e delle tinte neutre che | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Enrico Prampolini; Francesco Monarchi; Mino Somenzi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| 1 cappello veloce per l' uso quotidiano 2 cappello notturno per | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Enrico Prampolini; Francesco Monarchi; Mino Somenzi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| rivoluzione scagliandosi contro il cappello uniforme monotono d’ uso comune il pittore-scultore renato di bosso ed | ||
Di Bosso, Renato; Scurto, Ignazio (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gli italiani maschi a boicottare le cravatte d’ uso comune e ad usare la cravatta futurista lanciata | ||
Di Bosso, Renato; Scurto, Ignazio (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| infine di assumerne la paternità come è d’ uso con evidente malafede in certi rimaioli passatisti ma | ||
Giovanni Gerbino (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| architettura diviene arte quando oltre servire matematicamente all' uso genera in noi emozione ma ciò avviene | ||
Fillia (Luigi Colombo-Fillia) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| cammino del tempo fanno proprie e a solo uso personale idee principi e persino espressioni futuriste da | ||
Somenzi, Mino (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sintassi b distruzione della punteggiatura c uso di spazi bianchi per indicare le pause | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il suo valore tipico e totalitario f uso del verbo all’ infinito per adattarlo a tutta | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la rete delle sensazioni e analogie g uso delle onomatopee rumorismi e segni matematici h | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| delle onomatopee rumorismi e segni matematici h uso di caratteri tipografici e colori tipografici diversi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e colori tipografici diversi aggettivo-atmosfera i uso di parole riplasmate e deformate a scopo rumorista | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| riplasmate e deformate a scopo rumorista l uso di tavole sinottiche le parole in libertà hanno conquistato | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| poesia e nella prosa ne hanno fatto grandissimo uso spesso camuffandole con una falsa punteggiatura tipiche | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| disinvoltura di internazionale aristocrazia bolscevica eguali ed eguale uso ovunque per scopi ed ambienti dissimili e contrastanti | ||
Depero, Fortunato (1939) | ||
| vedi testo esteso | ||
| 3.000 parigine che affannosamente discutendo contro l’ uso dei giocattoli guerrieri esigevano il mio parere | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1940) | ||
| vedi testo esteso | ||
| minuto aggredendo qualsiasi eventuale rapitore abbandonare l’ uso ormai sistematico del crepuscolo della notte delle stelle | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini); Giovanni Acquaviva; Aldo Giuntini; Luigi Scrivo (1943) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sovrapposto all' architettura è un assurdo soltanto dall' uso e dalla disposizione originale del materiale greggio o | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||