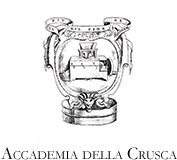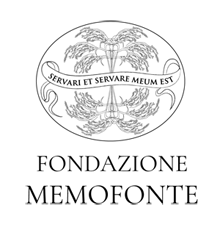Lista dei contesti relativa alla forma scelta
quelle
| veder galleggiare alla deriva lacere e stinte su quelle acque le vecchie tele gloriose impugnate i | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dovrebbe inventare se non esistesse guardate laggiù quelle spiche di grano allineate in battaglia a milioni | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di grano allineate in battaglia a milioni quelle spiche agili soldati dalle baionette aguzze glorificano la | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| della brezza ma guardate lassù a destra quelle spole azzurre sono i pazzi che cullano | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| immaginazioni giovanili alla figura stucchevole del don giovanni quelle violente e dominatrici di napoleone di clémenceau e | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di venezia e potrete ridendo con me considerare quelle isole come mucchi di sterco che i mammouth | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| risolutamente a tutti quegli artisti e a tutte quelle istituzioni che pur camuffandosi d' una veste di | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sanno più trovare melodie alludendo senza dubbio a quelle di rossini di bellini di verdi o di | ||
Balilla Pretella (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dovrebbe inventare se non esistesse guardate laggiù quelle spiche di grano allineate in battaglia a | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| grano allineate in battaglia a milioni quelle spiche agili soldati dalle baionette aguzze glorificano la | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| della brezza ma guardate lassù a destra quelle spole azzurre sono i pazzi che cullano | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| esterna concreta e l' emozione interna astratta quelle linee quelle macchie quelle zone di colore apparentemente | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e l' emozione interna astratta quelle linee quelle macchie quelle zone di colore apparentemente illogiche e | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| emozione interna astratta quelle linee quelle macchie quelle zone di colore apparentemente illogiche e inesplicabili sono | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tutte queste manifestazioni della scultura ed anche in quelle che hanno maggior soffio di audacia innovatrice si | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| rincorrersi agilmente fra le linee del cappello e quelle del collo così dei piani trasparenti dei | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e non accoppiare e non compiere se non quelle che possono completarsi ed esaltarsi con la | ||
de Saint-Point, Valentine (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| orchestre triplicate nel numero degli esecutori rispetto a quelle di allora il nostro orecchio invece se | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i rivoltosi cinesi le suffragette di londra e quelle di new york il dottor carrel e le | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le costruzioni pittoriche degl impressionisti come contaminava già quelle dei loro predecessori corot e delacroix 4 | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| della scala diatonica naturale e coll’ adozione di quelle differenze enarmoniche di comma che i nostri intonarumori | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| io impiego di solito il carattere corsivo per quelle mie parole in libertà che esprimono l' infinitamente piccolo e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| già libere dinamiche e siluranti tutte le velocità quelle degli astri delle nuvole degli aeroplani dei treni | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| o di bronzo che voi potete opporre a quelle inimitabili che ci furono lasciate dai secoli defunti | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| fino al cielo nell' epoca nostra i pinnacoli di quelle maestose cattedrali che salivano verso le nuvole giungendo | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
intanto comincia già ad essere disgustato di quelle che noi combattiamo noi abbiamo già provocato | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| una nuova sostanza esplosiva più micidiale di tutte quelle che finora si conoscono questa nuova terribile | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forza inscatolarsi nell' una o nell' altra di quelle ridicole limitazioni che si chiamano musica letteratura pittura | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tutte le arti già esistenti e di tutte quelle che sono e che saranno create dalla inesauribile | ||
Corradini, Bruno; Settimelli, Emilio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| religiosi e degli ordinamenti politici ma sono rarissime quelle cause di profondo mutamento nelle condizioni dell' ambiente | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
- che le linee oblique e quelle ellittiche sono dinamiche per la loro stessa natura | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la parola libertà e su tutte le parole quelle di genio e di originalità 3 | ||
Aldo Palazzeschi; Giovanni Papini; Ardengo Soffici (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di forme nuove se non che mancando assolutamente di quelle vere basi teoriche incapace di quelli approfondimenti le | ||
Aldo Palazzeschi; Giovanni Papini; Ardengo Soffici (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la pornografia la quale infatti mancava interamente a quelle tipiche opere marinettiste che sono il roi bombance | ||
Aldo Palazzeschi; Giovanni Papini; Ardengo Soffici (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| più impacciate più regolate e più prevedibili di quelle che si svolgono nel campo dell' arte è | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Emilio Settimelli; Bruno Corradini (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| atti e pronti alla guerra d oggi e a quelle di domani le sue riserve di denaro non | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| certe zone saranno meno fruttifere ma anche per quelle si tratta di lavoro e io non esito | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1915) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gemito d' orsi ecc quei negozianti e quelle vendite famose furono disastrose per l' arte napoletana | ||
Boccioni, Umberto (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| uno di quei guappi o ad una di quelle prostitute che ho avuto il piacere di conoscere | ||
Boccioni, Umberto (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gesticolazioni del tribuno più o meno decorative né quelle languide d' una prostituta sul corpo di un | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vagoni-ristoranti mangiare in velocità le stazioni ferroviarie specialmente quelle dell' oves-tamerica dove i treni lanciati a 140 | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dotate di un grado di intelligenza superiore a quelle di tutte le altre la complicatezza della loro | ||
Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Arnaldo Ginanni-Corradini (Ginna); Remo Chiti; Emilio Settimelli; Mario Carli; Vieri Nannetti; Oscar Mara (Attilio Franchi) (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mimica e musica etc 2 a quelle arti che si servono in comune o di | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| conclusioni pratiche con l' esporre parte per parte quelle mie innovazioni all’ opera d’ arte per il | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| è la vita tutto vive nel mondo anche quelle cose che gli scienziati hanno chiamato inanimate | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| operosità dei minatori e tutti in genere per quelle virtù caratteristiche del sardo che fanno di lui | ||
Marica, Pasquale (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti siamo convinti che solo per mezzo | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Bruno Corra (Ginanni-Corradini); Emilio Settimelli; Arnaldo Ginna (Ginanna-Corradini); Giacomo Balla; Remo Chiti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| difendono la musica tedesca sono i fratelli di quelle schifose signorine che portarono fiori e sorrisi ai | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| domatori di forze primordiali regolano il tiro di quelle batterie che lanciano fra le dighe di un | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la lingua del suo pensiero sono italiani perchè quelle medesime alpi dinariche che dal monte velebit al | ||
Orano, Paolo (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| più capace d’ una transazione come sono state quelle del cinquantanove e del sessantasei l’ italia | ||
Orano, Paolo (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vittoria esterna si possano posare per attendere a quelle interna non c’ è più modo ad | ||
Orano, Paolo (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| saperla guardare dà l’ ebbrezza certamente più di quelle feste governative che gli antichi facevano in onore | ||
Bruno, Antonio (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creatrici è costituito dalle varie architetture e da quelle produzioni che fra tutte le lavorazioni della materia | ||
Bragaglia, Anton Giulio (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che il pensiero umano espresso ha deposto su quelle lettere 2° l’ alfabeto contiene oggi per | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| storte vasi deformi ecc sono facilissime in quanto quelle bottiglie o quei vasi possono essere storti e | ||
Dudreville, Leonardo; Funi, Achille; Russolo, Luigi; Sironi, Mario (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| questi ultimi tempi si è montato di tutte quelle influenze esotiche che possiamo senz' altro dichiarare dannose | ||
Gino Galli (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| per fare dell' arte vera allontaniamoci da tutte quelle ciarlatanerie e persuadiamoci che occorre invece fare prima | ||
Gino Galli (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
2 il 2oo guadagneranno risparmiando quelle case che si daranno senza pregiudizi alla pubblicità | ||
Cantarelli, Gino (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| all' esterno con dinamiche forme colorate molto simili a quelle di boccioni di balla e di russolo | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| teatro le nostre idee assolutamente opposte a quelle imperanti sui palcoscenici d' italia e dell' estero | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ammirare imitare e plagiare soltanto una parte di quelle opere raffaello avendo scelto per un suo | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| babilonese la cinese l’ indiana ecc oltre quelle americane degli atzechi e degli incas avevano un’ | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sempre più a furia di chiamare al maschile quelle parti del corpo umano femminile possono suggestionarsi al | ||
Cangiullo, Francesco (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sensibilità le quali continuando a chiamare al femminile quelle parti del corpo umano maschile un giorno non | ||
Cangiullo, Francesco (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| razze dalle antidiluviane paurosissime e gigantesche a quelle piccolissime degli uccelli-mosca americani ho ammirato un’ | ||
Fortunato Depero (1927) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nell’ insieme esaminando le vetrine dei minerali quelle dei volatili coleotteri imbalsamati farfalle e lumache osservando | ||
Fortunato Depero (1927) | ||
| vedi testo esteso | ||
| d’ aria pieno di silenziose molle incerte quanto quelle delle poltrone di un pubblico severo la | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
le seconde cioè le forze astratte sono quelle che elevano trasformano la realtà in fantasia in | ||
Fortunato Depero (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| una intensità che non ha confronti rispetto a quelle vissute nella vita bastano poche ore dinanzi | ||
Depero, Fortunato (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sicure tanto più quando a sistemazione generale quelle 50 lire varranno sostanzialmente le 100 | ||
Camuzzi, Carlo (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| costellazioni a portata di mano per consolarci di quelle irraggiungibili gli avvisi luminosi sono i profondi | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forma astratta ideale intossicazione dal giorno di quelle esperienze pittoriche ad oggi sono passate dentro di | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| attraverso linee caratteristiche nè più nè meno di quelle che sul corpo e sul viso umano dimostrano | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| elementi ma a noi interessa soltanto di scoprirvi quelle linee-forza che presentammo nel primo esempio le | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| in funzione di forze temporanee in questo caso quelle delle nubi possono compenetrare l’ ambiente con le | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che noi percepiamo e che ci interessano sono quelle dell' intelligenza delle cose alla nostra investigazione | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| questo dove le rappresentazioni sono più sintetiche di quelle del mondo tangibile ma dove si fucinano i | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di aderire nell' unità assoluta allo sviluppo di quelle forme plastiche naturali che hanno sempre costituito nei più | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tra le regole dell' arte di edificare e quelle immanenti della natura qualità che dominano le | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le caratteristiche architettoniche e paesistiche delle campagne a quelle delle città intanto oggi i metodi di | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e invisibili anzi più a fondo contro quelle invisibili ecco il punto scopo principale | ||
Cervelli, Fernando (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| defunto sostanziabile e tangibile assai differente da quelle dubbie ed incontrollabili di precedenti religioni che | ||
Scurto, Ignazio (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| si accusano le nuove case di essere simili a quelle tedesche o cecoslovacche accusa facile da smentire col | ||
Fillia (Luigi Colombo-Fillia) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| defunto sostanziabile e tangibile assai differente da quelle dubbie ed incontrollabili di precedenti religioni che | ||
(1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| hanno condotto le mie ricerche che sono poi quelle che continuerò a sviluppare dirò che non ho | ||
Alberto Sartoris (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| arte è stato chiaro le architetture gotiche o quelle barocche avevano una loro scultura e una loro | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
le uniche opere di genere storico sono quelle vissute dalla nostra stessa generazione o da quella | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| del passato se entriamo in una di quelle abitazioni ci angoscia la pigiatura degli individui ognuno | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Angiolo Mazzoni; Mino Somenzi (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e un nuovo amore diverse sensibilità opposte a quelle del passato senza che tutto ciò abbia conferma | ||
Somenzi, Mino (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| con le seguenti virtù cinematografiche da aggiungere a quelle segnalate all’ inizio di questo articolo 1 | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| incominciato col sovvertire le leggi grammaticali e specie quelle del costrutto che impongono alle parole una dipendenza | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| d’ immagini capaci di trasportare il lettore verso quelle zone poetiche determinanti rapporti d' amore e di | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Luigi Scrivo; Piero Bellanova (1939) | ||
| vedi testo esteso | ||
| raccolti con la massima libertà passando da quelle parti mi rompevo il braccio per tenere al | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| esaltazione di tali doti positive e col portare quelle negative magari con la violenza e la crudeltà | ||
Maria Goretti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
la calma e la profonda bellezza di quelle opere era dovuta anche alla loro funzione ambientale | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| indiscutibilmente legato alle grandi epoche costruttive che sono quelle dei grandi interrogativi sociali dove l' artista se | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dove convergono e coincidono le facoltà sensoriali e quelle affettive dalla confluenza di queste due dimensioni | ||
Enrico Prampolini (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||