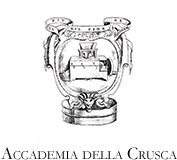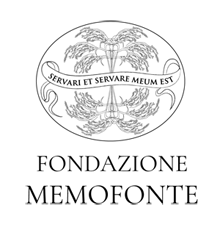Lista dei contesti relativa alla forma scelta
stessi
| furente scopa della pazzia ci strappò a noi stessi e ci cacciò attraverso le vie scoscese e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| bianchi e fissi dell’ ideale e noi stessi daremo l’ esempio abbandonandoci alla furibonda sarta delle | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vostro difetto maggiore un difetto del quale voi stessi avete dotata l' europa e che a parer | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1910) | ||
| vedi testo esteso | ||
| bianchi e fissi dell' ideale e noi stessi daremo l' esempio abbandonandoci alla furibonda sarta delle | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ricerche abbiamo rapidamente maturato e superato in noi stessi tutte le meravigliose fasi della pittura francese nel | ||
Boccioni, Umberto; Carrà, Carlo; Russolo, Luigi; Balla, Giacomo; Severini, Gino (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| carattere di creazione universale ha quindi gli stessi pregi e difetti dell' impressionismo pittorico dalle cui | ||
Boccioni, Umberto (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| rapporti rilevati tra accento e movimento sono gli stessi fra movimento e misura di tempo misura | ||
Balilla Pratella, Francesco (1912) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a paragone delle altre arti i greci stessi con la loro teoria musicale matematicamente sistemata da | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inebbriarsi della vita e di inebbriarla di noi stessi la facoltà di cambiare in vino l' | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| fra il pubblico e il poeta i rapporti stessi che esistono fra due vecchi amici questi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nei suoni adoperabili e reso stranamente artificiali quelli stessi che si adoperano si sa quanto sia | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a quella in tono di re intonerà gli stessi gradi non più come prima ma coi rapporti | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
osservate i loro articoli sono sempre gli stessi aggettivi gli stessi luoghi comuni lo stesso | ||
Carrà, Carlo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| loro articoli sono sempre gli stessi aggettivi gli stessi luoghi comuni lo stesso gergo quarantottesco è | ||
Carrà, Carlo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| essere l' immediata e fedele proiezione di noi stessi così quest arte espressiva e sintetica è | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| scultura non suscitano oggi nella massa umana gli stessi fenomeni di ebbrezza travolgente suscitativi dalla musica non | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| equivalente pittorico di forma dominando gli oggetti stessi e comprendendoli noi creiamo un equivalente lineare geometrico | ||
Emilio Notte; Lucio Venna (Giuseppe Landsmann) (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| è futuristi o influenzati o simpatizzanti gli stessi accademici propongono l’ abolizione delle accademie questo | ||
Emilio Settimelli (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| colorati aerei formati con fumi diffusi da loro stessi e di notte comporranno mobili costellazioni e danze fantastiche | ||
Fedele Azari (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| contatti con qualunque cattedra dobbiamo levarci e quelli stessi che sono serrati sotto il giogo del classicismo | ||
Roberto Clerici; Michele Leskovich; Pietro Albrighi (1921) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le istituzioni statali comunali private e gli artisti stessi proposta prampolini marasco marinetti volt 10° | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| materiale espressivo ma che sono fine esclusivamente a se stessi perciò questi artisti caddero spesso nel falso | ||
Enrico Prampolini; Ivo Pannaggi; Vinicio Paladini (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| costruzione e quindi più perfezionati ma anche quegli stessi di prima fabbricazione che trovandosi in pochi timidi | ||
Azari, Fedele (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| secondarie derivate dalle precedenti perché importate con gli stessi mezzi e gli stessi fini in una limitazione | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| perché importate con gli stessi mezzi e gli stessi fini in una limitazione espansiva mentre maturavano i | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| pulsa fuori della camera perchè porta nei suoi stessi sensi nei suoi nervi il riverbero di quanto | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| si esprime nelle sue dotte conferenze coi principi stessi del futurismo originalità rinnovarsi finiamola con la tradizione | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ombre degli oggetti contrastanti e isolate dagli oggetti stessi 3° il dramma di oggetti umanizzati pietrificati cristallizzati | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Sansoni, Guglielmo (Tato) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| simultaneita questa facoltà raggiunge infatti praticamente gli stessi risultati della velocità napoleone dettava più lettere | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| molti altri il quotidiano l’ impero negli stessi anni attraverso inchieste e collaborazioni di futuristi agitò | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| case bonificarono terreni svilupparono industrie oggi gli stessi stretti dalla necessità di pagare interessi e restituire | ||
Camuzzi, Carlo (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| materiale espressivo ma che sono fine esclusivamente a se stessi perciò questi artisti caddero spesso nel falso | ||
Enrico Prampolini (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che si sono man mano spinte oltre gli stessi confini della pittura e dell’ arte il | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| investigazioni basta che per natura o da noi stessi o comunque sia costruita una forma materiale perchè | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| delle stesse cose sempre e sempre a gli stessi grappoli lagrimosi di pensionati in cerca di sole | ||
Cervelli, Fernando (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| individualità pur nella medesima struttura e con gli stessi mezzi tecnici bisogna anzi convincersi che la | ||
Fillia (Luigi Colombo-Fillia) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nuova architettura ha i suoi valori ornamentali nei materiali stessi che la compongono nello splendore geometrico delle sue | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| architettura interna l’ ornamento è dato dai materiali stessi escludo ogni apporto freddo o inadatto cosi | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ambienti privali e pubblici sono belli in sè stessi con lo splendore delle loro pareti nude o | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inebbriarsi della vita e di inebbriarla di noi stessi la facoltà di cambiare in vino l’ | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ritorni al passato aeropoeti e aeropittori noi stessi troviamo un da fare tipico nell’ aeropoesia sintesi | ||
Buccafusca, Emilio; Forlin, Corrado; Averini, Riccardo; Ganzaroli, Walter; Stoppele, Rino; Pattarozzi, Gaetano; Pennone, Luigi; Veronesi, Ugo (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ordini della luna domani agli ordini degli aeropittori stessi muniti di pennelli correnti elettriche intinti della scorrevole | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gli aeroplani aeropoeticamente possono essere paragonati a sé stessi o ad altre macchine mai ad aquile falchi | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gli aeroplani aeropoeticamente possono essere paragonati a sé stessi o ad altre macchine mai ad aquile falchi | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini); Giovanni Acquaviva; Aldo Giuntini; Luigi Scrivo (1943) | ||
| vedi testo esteso | ||