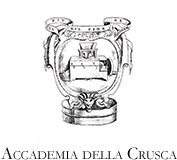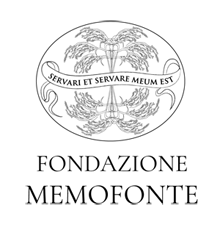Lista dei contesti relativa alla forma scelta
rumore
sussultammo ad un tratto all' udire il rumore formidabile degli enormi tramvai a due piani che | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a quando si stendeva a terra con un rumore di mascelle stridenti mandandomi da ogni pozzanghera sguardi | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tratto un grido altissimo lacerò l’ aria un rumore si propagò tutti accorsero era un pazzo | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tratto un grido altissimo lacerò l' aria un rumore si propagò tutti accorsero era un pazzo | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1911) | ||
| vedi testo esteso | ||
| secolo coll' invenzione delle macchine che nacque il rumore oggi il rumore trionfa e domina sovrano | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| macchine che nacque il rumore oggi il rumore trionfa e domina sovrano sulla sensibilità degli uomini | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| orecchio ci avviciniamo così sempre più al suono-rumore questa evoluzione della musica è parallela al | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| orecchio ci avviciniamo così sempre più al suono-rumore questa evoluzione della musica è parallela al | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creazione del rumore musicale questa evoluzione verso il suono-rumore non era possibile prima d' ora l' | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creazione del rumore musicale questa evoluzione verso il suono-rumore non era possibile prima d' ora l' | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| usciamo non si potrà obiettare che il rumore sia soltanto forte e sgradevole all' orecchio | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forte e predominante di queste vibrazioni il rumore infatti si differenzia dal suono solo in quanto | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sia nel tempo che nella intensità ogni rumore ha un tono talora anche un accordo che | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di intonarlo di dare cioè ad un dato rumore non un solo tono ma una certa varietà | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ogni manifestazione della nostra vita è accompagnata dal rumore il rumore è quindi famigliare al nostro | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nostra vita è accompagnata dal rumore il rumore è quindi famigliare al nostro orecchio ed ha | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| all' occhio è un viso troppo noto il rumore invece giungendoci confuso e irregolare dalla confusione irregolare | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nuova voluttà insospettata benché la caratteristica del rumore sia di richiamarci brutalmente alla vita l' arte dei rumori | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di questi i movimenti ritmici di un rumore sono infiniti esiste sempre come per il | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sempre più dal suono puro giungono quasi al suono-rumore questo bisogno e questa tendenza non potranno | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sempre più dal suono puro giungono quasi al suono-rumore questo bisogno e questa tendenza non potranno | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| soddisfatti che coll' aggiunta e la sostituzione del rumore ai suoni 2 i musicisti futuristi | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| modo di ampliarsi e rinnovarsi dato che ogni rumore offre l' unione dei ritmi più diversi oltre | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a quello predominante 4 ogni rumore avendo nelle sue vibrazioni irregolari un tono generale | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| varietà di toni non toglierà a ogni singolo rumore le caratteristiche del suo timbro ma ne amplierà | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
trovato il principio meccanico che dà un rumore si potrà mutarne il tono regolandosi sulle stesse | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dall' affrontare le difficoltà del suono e del rumore e dell' odore in pittura essi preferirono rinculare | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| portando nella pittura l' elemento suono l' elemento rumore e l' elemento odore tracciamo nuove strade | ||
Carrà, Carlo Dalmazio (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| lento dell' erudito e del professorale è il rumore stridente di tutti i picconi demolitori è un | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i motori elettrici questo salire o scendere del suono-rumore per quanto graduatissimo è percepito tuttavia nel suo | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| i motori elettrici questo salire o scendere del suono-rumore per quanto graduatissimo è percepito tuttavia nel suo | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| se anzi in natura come abbiamo visto il suono-rumore esiste solo con questi suoni e se questi | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| se anzi in natura come abbiamo visto il suono-rumore esiste solo con questi suoni e se questi | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| del suono come qualità o timbro il rumore infatti non è altro che un suono ricchissimo | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| cercato non solo la possibilità di cambiare il suono-rumore per tono e semitono ma anche quella di | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| cercato non solo la possibilità di cambiare il suono-rumore per tono e semitono ma anche quella di | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inutile aggiungere che poiché col sistema enarmonico il suono-rumore può prendere l’ intonazione che si vuole si | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inutile aggiungere che poiché col sistema enarmonico il suono-rumore può prendere l’ intonazione che si vuole si | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| esistono delle varietà di timbro in uno stesso rumore mi spiegherò con un esempio in | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| su uno stesso tono e con lo stesso rumore si pensi ora con rumori diversi come | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| passaggi enarmonici coi timbri diversi di uno stesso rumore quale ricchezza e vastità di sensazioni ci serbi | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le forme noi abbiamo finalmente la materia suono-rumore capace di assumere tutte le forme senza eccezione | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le forme noi abbiamo finalmente la materia suono-rumore capace di assumere tutte le forme senza eccezione | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le nuove significazioni della luce del suono del rumore e della parola coi loro prolungamenti misteriosi e | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| noi e pompano i quattrini della nazione rumore lancio di patate arance carole le esposizioni | ||
Carrà, Carlo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ci spingono all' uso dell' onomatopea il rumore essendo il risultato dello strofinamento o dell' urto | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gas in velocità l' onomatopea che riproduce il rumore è necessariamente uno degli elementi più dinamici della | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mio poema dune l' onomatopea dum-dum-dum-dum esprime il rumore rotativo del sole africano e il peso arancione | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tra sensazioni di peso calore colore odore e rumore altro esempio l' onomatopea stridionla stridionla stridionlaire | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| astratta ran ran ran non corrisponde a nessun rumore della natura o del macchinismo ma esprime uno | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ci spingono all’ uso dell’ onomatopea il rumore essendo il risultato dello strofinamento o dell’ urto | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gas in velocità l’ onomatopea che riproduce il rumore è necessariamente uno degli elementi più dinamici della | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mio poema dune l’ onomatopea dum-dum-dum-dum esprime il rumore rotativo del sole africano e il peso arancione | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tra sensazioni di peso calore colore odore e rumore altro esempio l' onomatopea stridionla stridionla stridionlaire | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| astratta ran ran ran non corrisponde a nessun rumore della natura o del macchinismo ma esprime uno | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| generatori di movimento coi nostri prolungamenti meccanici col rumore e colla velocità della nostra vita potessimo vivere | ||
Sant'Elia, Antonio (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| superarli nei caffè nei ristoranti caldi di rumore e di fumo nereggianti di fraks scintillanti di | ||
Boccioni, Umberto (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il golfo passatista di napoli il putipù rumore arancione chiamato anche caccavella o pernacchiatore piccola scatola | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nostalgici del chiaro di luna lo scetavaiasse rumore rosa e verde che ha per archetto una | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| noia e di tetraggine deprimente il triccabballacche rumore rosso è una specie di lira di legno | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e perciò raramente utilizzabile nella danza futurista il rumore essendo il risultato dello strofinamento o dell' urto | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| degli elementi più dinamici della poesia futurista il rumore è il linguaggio della nuova vita umano-meccanica la | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
la fusione delle canzoni umane carnale col rumore meccanico e distruttore dare la sintesi ideale | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| utensile d' acciaio nella vasta officina policromia di vita-rumore fontana di genialità qualche cosa bolliva in | ||
Roberto Clerici; Michele Leskovich; Pietro Albrighi (1921) | ||
| vedi testo esteso | ||
| utensile d' acciaio nella vasta officina policromia di vita-rumore fontana di genialità qualche cosa bolliva in | ||
Roberto Clerici; Michele Leskovich; Pietro Albrighi (1921) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la plastica futurista nel suo manifesto costruzione assoluta di moto-rumore nel 1916 il pittore severini spiega | ||
Enrico Prampolini; Ivo Pannaggi; Vinicio Paladini (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la plastica futurista nel suo manifesto costruzione assoluta di moto-rumore nel 1916 il pittore severini spiega | ||
Enrico Prampolini; Ivo Pannaggi; Vinicio Paladini (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| specialmente nel caso più facilmente avvertibile per il rumore del così detto imballamento ad ogni modo | ||
Azari, Fedele (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e continenti e ai paesaggi di colore forma rumore che la radio-televisione fa navigare intorno alla terra | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
10 vita caratteristica di ogni rumore e infinita varietà dì concreto-astratto e fatto-sognato mediante | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che avvolge e colora una data voce suono rumore 20 eliminazione del concetto e | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gli ascoltatori costrigendoli ad accettare la nobiltà del rumore in poesia il successo divenne così pateticamente | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mare e cielo verbalizzate dal futurismo il rumore diventò presto la vita essenziale significativa e spiritualizzante | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tooorna dell’ aeroplano sul bersaglio zaaaaim aaare del rumore dell’ aerocaccia in volo planaaaaaaa viiiiraaaaa della | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a caricarlo coi forconi non avrebbe fatto più rumore di palate di argilla si sarebbe sentito | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||