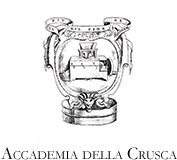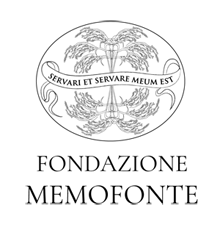Lista dei contesti relativa alla forma scelta
un’
| fu male poiché rapidamente con la facilità di un’ aurora che si propaga sul mare una verdura | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quando c’ è vento garrisce sulle vette come un’ immensa bandiera e i pazzi rapirono mantelli | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| acciaio e si parte nell’ ebbrezza di un’ agile evoluzione con un volo vivace crepitante leggiero | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1909) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ciò che è peggio si è portata così un’ enorme limitazione nel numero dei suoni adoperabili e | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sistema di scrittura musicale e di questo parlerò un’ altra volta mi sembra inutile aggiungere che | ||
Luigi Russolo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| filosofica ed erudita altro non è se non un’ enorme pisciata di boriose chiacchiere sibili pernacchi trombette | ||
Carrà, Carlo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| si merita però oggi il popolo italiano ha un’ arte che non merita affatto l’ arte futurista | ||
Carrà, Carlo (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nascita di un’ estetica futurista 1913 ma certamente numerose | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dai selciati erbosi di silenzio noi respiriamo un’ atmosfera che a loro sarebbe parsa irrespirabile | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1913) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vibrazione di sirena o il trapano di un’ elica dentro l’ acqua nemmeno il cielo cupola | ||
Folgore, Luciano (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mio poema epico la conquete des etoiles forma un’ analogia fra lo stridore di grandi spade e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1914) | ||
| vedi testo esteso | ||
| un dramma in prosa o in versi un’ opera per il teatro si stati d’ | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ma non mai sensuali di conseguenza in un’ opera per il teatro il parallelismo di espressione | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| danza complementare e viceversa etc riassumendo in un’ opera per il teatro due arti che si | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| per giungere a sen-tire ed a conoscere pienamente un’ opera di creazione artistica occorre credere in essa | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e le cadenze debbono senz’ eccezione corrispondere ad un’ interruzione logica o ad una posa del senso | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| modo si concepisca l’ arte del gesto un’ armonia un ritmo ininterrotto e costantemente vario di | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| lo dovrà indossare colori e forme riflettenti un’ anima una volontà una funzione estetica un momento | ||
Balilla Pratella, Francesco (1916) | ||
| vedi testo esteso | ||
| commentatori dei professori e degli albergatori preparazione d’ un’ atmosfera favorevole ai novatori temerità per un infinito | ||
(1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| concetto strutturale dell’ allestimento scenico ma di creare un’ entità astratta che si identifichi con l’ azione | ||
Prampolini, Enrico (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| scena non sarà più uno sfondo colorato ma un’ architettura elettromeccanica incolore vivificata potentemente da emanazioni cromatiche | ||
Prampolini, Enrico (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| kilowatts si diffondono dovunque senza fili conduttori con un’ abbondanza fertilizzante regolata da tastiere che vibrano sotto | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| meschino quanto il pensare all’ immortalità nel creare un’ opera d’ arte più meschino e più basso | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| una strada bianca dove bruscamente s’ arresta tossendo un’ automobile scintillante di progresso e piena di voci | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| genio indiscutibile resterà nondimeno colpevole d’ avere esercitato un’ influenza avvilente e deleteria siamo ben lieti | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
all’ arte astratta statica e formale noi opponiamo un’ arte di movimento continuo di lotta aggressiva di | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sanno ed esperimentano che non è più con un’ italia romantica che il mondo tratta e tanto | ||
Orano, Paolo (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le fondamenta di tutti i valori acquisiti in un’ ansia di rinnovamento che a saperla guardare dà | ||
Bruno, Antonio (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forma di pigrizia mondana speculativa o virtuistica determina un’ atmosfera elastica vibrante sferzata d' intransigente originalità che | ||
Bruno, Antonio (1917) | ||
| vedi testo esteso | ||
| industria si ricava il 7,50 e nondimeno un’ azione di 100 lire di questa industria | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| equilibrio sociale la grande idea è lanciata un’ idea che ha la potenza di un profondo | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| abbandonare l’ azienda od officina per recarsi in un’ altra 2 le maestranze sarebbero sempre | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| copia decadenza ibrido baraonda stilistica indecisione mancanza di un’ architettura a spiccati caratteri di italianità assenza di | ||
Virgilio Marchi (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| inesistenti logorio di gioventù tutto in omaggio a un’ assurda mentalità negatrice deprimente sopraffattrice che non ammette | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dai giornali conservatori il movimento futurista svolse prima un’ azione prevalentemente artistica influenzando non di meno energicamente | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Emilio Settimelli; Mario Carli (1919) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dal mare o da un lago o da un’ estesa pianura il fiorire l’ innalzarsi l’ espandersi | ||
Cantarelli, Gino (1920) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ideali che superano la vita antica di quanto un’ officina supera il porcile perciò noi vi | ||
Jannelli, Guglielmo; Nicastro, Luciano; Di Giacomo, Giovanni Antonio (Vann'Antò); Carrozza, Francesco; Raciti, Aldo (1921) | ||
| vedi testo esteso | ||
| vogliamo chiudere l’ attività personale nel cerchio di un’ organizzazione ma creare la possibilità di un rapido | ||
Bracci, Tullio Alpinolo; Colombo, Luigi (Fillia) (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il mezzo più sicuro e più meraviglioso di un’ azione formidabile perché arte e lavoro rappresentano creazione | ||
Bracci, Tullio Alpinolo; Colombo, Luigi (Fillia) (1923) | ||
| vedi testo esteso | ||
| primissimo del genio rinnovatore è quello di creare un’ estetica fra i creatori di estetiche moderne possiamo | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| indissolubilmente legato alla nostra epoca 2 un’ auto un grattacielo americano sono ponti lanciati arditamente | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le vecchie sensibilità barocche la costruzione architettonica di un’ auto ferro latta alluminio curve atmosferiche elasticità dinamismo | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la ignora non permettono la creazione adeguata dì un’ estetica intuitivamente moderna quello che già avvenne | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| grandi artisti della nostra epoca saranno i creatori di un’ estetica al pubblico malato di letteratura ammuffita | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| non letteraria destinata a fissare le basi di un’ arte solidamente ambientata e opportuno e necessario | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creazione meccanica inumana solo superficialmente incapace di produrre un’ emozione fattrice indispensabile dell’ opera dalla macchina | ||
Carmelich, Giorgio (1924) | ||
| vedi testo esteso | ||
| anni soltanto cominciamo a comprendere la potenzialità di un’ epoca nuova liberata dalla vecchia atmosfera di valutazioni con | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| affermazione futurista ha dato elementi tali da impostare un’ architettura conclusiva soltanto esasperando la portata di queste | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| affrettarne la fatale diffusione eliminando i residui di un’ erronea mentalità l’ arte ritorna ad essere | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
possiamo così paradossalmente fissare la necessità di un’ arte sacra meccanica le conquiste tecniche del futurismo | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creano un tutto indivisibile di valori un complesso plastico un’ altra estetica come una macchina l’ opera | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| diversi ma indispensabili al suo funzionamento espressivo cioè un’ architettura spaziale-cromatica ecco dunque che come un | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nell’ applicazione industriale e commerciale e richiedono appunto un’ unità d’ azione per affermare la propria superiorità | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1925) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quelle americane degli atzechi e degli incas avevano un’ identica forma morale di vita le differenze di | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ci stiamo lentamente formando ogni uomo possiede un’ intuizione atavica che esaurisce le emozioni conosciute fino | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| creano un tutto indivisibile di valori un complesso architettonico un’ altra estetica come la macchina l’ opera | ||
Fillia (Luigi Colombo); Pino Curtoni; A.C. Caligaris (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| per la sua azione il centro assoluto di un’ infinità di oggetti e di derivazioni dipendenti noi | ||
Fillia (Luigi Colombo); Pino Curtoni; A.C. Caligaris (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la forma della velocità questa costruzione ambientale genera un’ architettura di movimento dove la bicicletta é superiore | ||
Fillia (Luigi Colombo); Pino Curtoni; A.C. Caligaris (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| agli oggetti reali creando con questi al guidatore un’ atmosfera di sensualità chi guarda il quadro | ||
Fillia (Luigi Colombo); Pino Curtoni; A.C. Caligaris (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| scinde i raggi luminosi fasciando la fusoliera di un’ attillato vestito spirale multicolore l' apparecchio intero si | ||
Fillia (Luigi Colombo); Pino Curtoni; A.C. Caligaris (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a lei quando guarnito in quel modo diventa un’ altra cosa ancora una prova di questo | ||
Cangiullo, Francesco (1926) | ||
| vedi testo esteso | ||
fui preso da un amore febbrile da un’ ansia spasmodica tormentante di superare il quadro per | ||
Fortunato Depero (1927) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quelle piccolissime degli uccelli-mosca americani ho ammirato un’ infinita varietà di strutture ossee d’ un’ evidenza | ||
Fortunato Depero (1927) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ammirato un’ infinita varietà di strutture ossee d’ un’ evidenza schematica meravigliosamente complicata nei dettagli ed armoniosamente | ||
Fortunato Depero (1927) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e speciali oggi il fascismo vincitore esige un’ assoluta disciplina politica mentre il futurismo vincitore esige | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| assoluta disciplina politica mentre il futurismo vincitore esige un’ infinita libertà creatrice ciò forma un complementarismo armonioso | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| premio della futura biennale veneziana da destinarsi ad un’ opera di soggetto fascista risponde al nostro concetto di | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dalla doppia religione dell' originalità potente e di un’ italia divina f t marinetti trentatre | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1929) | ||
| vedi testo esteso | ||
| o di un gruppo di persone ottenute con un’ armonia una minuzia di particolari ed una tipicità | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Sansoni, Guglielmo (Tato) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il pranzo perfetto esige 1 un’ armonia originale della tavola cristalleria vasellame addobbo coi | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1930) | ||
| vedi testo esteso | ||
| spiritualità futurista un’ arte veramente universale e duratura un’ arte che | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| futurista un’ arte veramente universale e duratura un’ arte che sia per gli uomini necessità e | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ancora ehi paria dell’ arte bizantina come di un’ arte orientale con residui romani e greci quando | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il centro vivo ed operante della nuova religione un’ organicità perfetta animava l’ esistenza ih quell epoca | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l’ arte diviene nuovamente un piacere dei sensi un’ esaltazione delle bellezze naturali le madonne di raffaello | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| crearono il cubismo che fu nei primi anni un’ intensa ricerca costruttiva non più su basi illustrative o | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| rispondere a chi vuole ad ogni costo vedere un’ influenza del cubismo sul futurismo italiano ma quest | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| unitario che li anima tendenti cioè a raggiungere un’ ispressione artistica del secolo in italia resiste | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| si comprende o non si vuole comprendere che un’ arte è tale in quanto universale cioè mondialmente | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| francesi come se ciò diminuisse il valore di un’ opera ed impedisse un’ individualità vi è | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| diminuisse il valore di un’ opera ed impedisse un’ individualità vi è oggi uno spirito universale | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| con serietà sui valori e sui particolari di un’ opera tradizionale pretenderebbe dall’ arte nuova un movimento continuo | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| altra arte da quella bizantina al rinascimento ebbe un’ influenza diretta sul rinnovamento del decorativo e fornì | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| siano gli elementi che informano l’ esistenza di un’ atmosfera religiosa noi sosteniamo che l’ avvento | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quest affermazione pensando che l’ uomo conduce oggi un’ esistenza diversissima da quella di un tempo e | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| spirito che sorge dalla civiltà meccanica è possibile realizzare un’ arte che ci parli i nostri sentimenti | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| organizzazione diversa di valori umani e in conseguenza un’ altra sensibilità i misteri della lontananza e | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| un fenomeno puramente materiale la civiltà meccanica provoca un’ atmosfera di mistero di ignoto d’ imprevedibile ha | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| enigmi a proposito dei lavori futuristi ma più un’ arte è misteriosa più è grande ed eterna | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nostra epoca noi crediamo che si possa raggiungere un’ arte storicamente importante come quella egiziana e quella | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mattutina al posto ove intendono essere svegliati ad un’ ora prestabilita per riprendere le proprie occupazioni | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| uomini nostri i prodotti nostri hanno bisogno di un’ arte nuova altrettanto splendente altrettanto meccanica e veloce esaltatrice | ||
Depero, Fortunato (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| arte pubblicitaria- l’ arte della pubblicità è un’ arte decisamente colorata obbligata alla sintesi - arte | ||
Depero, Fortunato (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nuova prospettiva multipla una plastica aerea e volante un’ arte magnificamente dotata di tutte le qualità necessarie | ||
Depero, Fortunato (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| mondo la frase matricida la guerra mondiale è un’ inutile strage per parte dello stato italiano | ||
Settimelli, Emilio; Rosai, Ottone; Chiti, Remo; Maurizio, Alberto; Rosai, Bruno (1931) | ||
| vedi testo esteso | ||
| capolavori di arte sacra premesso d' altra parte che un’ arte senza evoluzione è destinata a morire il | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| terrestri e quindi incapaci d’ innalzarsi fino ad un’ astrazione mistica 3 soltanto gli aeropittori futuristi | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tato thayaht zucco ecc possono oggi precisare in un’ opera d’ arte sacra la beatitudine del paradiso superando | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di antitalianità i giovani italiani che cadono in un’ estasi cretina davanti a tutte le straniere anche | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| la propria attenzione grafica per delle ore su un’ immagine unica e statica cosicché dobbiamo considerare il | ||
Depero, Fortunato (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| le onoranze ad antonio sant’elia onoranze che ebbero un’ eco mondiale e contribuirono a fissare in modo | ||
Fillia (Luigi Colombo) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| il dramma dei sentimenti umani si compia in un’ atmosfera emotiva svincolata da ogni episodio storico e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Ambrosi, Alfredo; Anselmi, Piero; Aschieri, Bruno; Bertozzi, Renzo; Di Bosso, Renato; Scurto, Ignazio; Tomba, Ernesto Amos (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
sopprimere lo snervante intervallo di ben quasi un’ ora ottenendo un nuovo stato d’ animo scenico | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Ambrosi, Alfredo; Anselmi, Piero; Aschieri, Bruno; Bertozzi, Renzo; Di Bosso, Renato; Scurto, Ignazio; Tomba, Ernesto Amos (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| aeroporti e dal volo nelle parole in libertà di un’ aeropoesia si deve 1 distruggere | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| architetti italiani pur non essendo ancora realizzate dimostrano un’ ispirazione infinitamente più lirica e accanto agli | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1932) | ||
| vedi testo esteso | ||
| evitare il pericolo di far precipitare nel superato un’ arte per se stessa nemica di ogni sosta | ||
Antonio Marasco (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| titoli dei quadri essi che rappresentato ancora oggi un’ avanzatissima forma d arte pittorica puramente astratta cominciano con | ||
Ginna, Arnaldo (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| cemento ferro vetro ma non aveva forse ancora un’ esatta cognizione di quello che poteva essere una | ||
Cesare Augusto Poggi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ogni nostro atto cosciente subcosciente ed istintivo esiste un’ azione difensiva ed a tale scopo anche offensiva | ||
Cesare Augusto Poggi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| scienza per esempio una locomotiva un velivolo un’ automobile sono tanto più antiestetici quanto maggiore è | ||
Cesare Augusto Poggi (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e speciali oggi il fascismo vincitore esige un’ assoluta disciplina politica mentre il futurismo vincitore esige | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| assoluta disciplina politica mentre il futurismo vincitore esige un’ infinita libertà creatrice ciò forma un complementarismo armonioso | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| dalla doppia religione dell' originalità potente e di un’ italia divina aeropittura aeropoesia parolibera | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| alla natura i sistemi dell’ urbanismo europee hanno un’ importanza vitale in fatti è dallo studio | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e coll’ arte urbanistica vengono a spostarsi secondo un’ applicazione più in tensiva dei portati moderni | ||
Alberto Sartoris (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| gli italiani è preferibile essere decorati da un’ ala d’ aeroplano al sole che da uno | ||
Di Bosso, Renato; Scurto, Ignazio (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| maggior velocità di spostamento da un luogo ad un’ altro in confronto delle bighe dei carrettini e | ||
Govoni, Corrado (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ammaliziatissimi poeti la malafede si estende ad un’ altra incredibile affermazione sulla inutilità della poesia sempre | ||
Govoni, Corrado (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| alla tradizione è grottesco 2 un’ arte nuova che comincia dove cessano il teatro il | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| organismo di sensazioni radiofoniche 7 un’ arte senza tempo né spazio senza ieri e | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| parola-atmosfera le parole in libertà figlie dell’ estetica della macchina contengono un’ orchestra di rumori e di accordi rumori realisti | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| che ha sempre anche per il libro esercitato un’ influenza deformante e peggiorante questo manifesto è | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
eternamente giovane brillantemente futurista difatti un’ ondata improvvisa seguita da altre graziose sorelline capovolge | ||
Cervelli, Fernando (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| davanti a tutto e a tutti assumerà sempre un’ aria torbida di superiorità e di supremazia sfoggiando | ||
Cervelli, Fernando (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l’ uomo continuerà il suo essere in un’ oltrevita metallico e dinamico e non illusorio | ||
Scurto, Ignazio (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| prospettive aeree e conseguentemente il principio dell’ aeropittura è un’ incessante e graduata moltiplicazione di forme e colori | ||
Balla, Giacomo; Marinetti, Benedetta; Depero, Fortunato; Dottori, Gerardo; Colombo, Luigi (Fillia); Marinetti, Filippo Tommaso; Prampolini, Enrico; Somenzi, Mino; Sansoni, Guglielmo (Tato) (1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l’ uomo continuerà il suo essere in un’ oltrevita metallico e dinamico e non illusorio | ||
(1933) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e forma paesaggio-clima e forma-proporzioni 3 un’ assimmetria equilibrata da un’ armonia di piante e | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| forma-proporzioni 3 un’ assimmetria equilibrata da un’ armonia di piante e di masse 4 | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di piante e di masse 4 un’ utilizzazione completa dei nuovi materiali costruttivi e relative nuove | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| decorativo ma come forza architettonica 3 un’ audacia eccentrica di tettoie ballatoi balconi fasci d’ | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| correttori per l’ aggiornamento e l’ affermazione di un’ arte nazionale senza per questo ch’ egli sia | ||
Alberto Sartoris (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| accademia moderna si direbbe persino che da un’ esposizione di ordine generale in merito alla dottrina | ||
Alberto Sartoris (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| secondo della marcia del tempo si va compiendo un’ ardua impresa di salute pubblica all’ insegna della | ||
Alberto Sartoris (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ma nella formazione di un gusto o di un’ estetica dove hanno la possibilità di collaborare tutte | ||
Colombo, Luigi (Fillia) (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ai volatori simile ad una freccia un anello un’ elica un cuneo un crogiuolo un brillante una | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Angiolo Mazzoni; Mino Somenzi (1934) | ||
| vedi testo esteso | ||
| propaganda infallibile l' arte della pubblicità è un’ arte decisamente colorata obbligata agli elementi essenziali | ||
Fortunato Depero (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| per la sua esaltazione non è affatto un’ arte facile ma contrariamente è un' arte di | ||
Fortunato Depero (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| campo sono pochi ma senza dubbio è un’ arte che attrae l' artista per il suo | ||
Fortunato Depero (1937) | ||
| vedi testo esteso | ||
| combattuta del lavoro personalmente raffinato per raggiungere un’ efficacia la poesia dei tecnicismi deve nel magnificare | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| neghiamo che l’ anfiteatro antico possa ospitare un’ opera teatrale moderna né ispirare un dramma originale a | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Bruno Corra (Bruno Ginanni-Corradini) (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| autonomo tutte sottomesse alla patria che non è un’ idea nè un’ abitudine nè un complesso di | ||
Buccafusca, Emilio; Forlin, Corrado; Averini, Riccardo; Ganzaroli, Walter; Stoppele, Rino; Pattarozzi, Gaetano; Pennone, Luigi; Veronesi, Ugo (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| alla patria che non è un’ idea nè un’ abitudine nè un complesso di tradizioni ma un | ||
Buccafusca, Emilio; Forlin, Corrado; Averini, Riccardo; Ganzaroli, Walter; Stoppele, Rino; Pattarozzi, Gaetano; Pennone, Luigi; Veronesi, Ugo (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| quasi divino assorbente il secondo da raggiungersi con un’ esperienza di vita il terzo decisivo ma diabolico | ||
Buccafusca, Emilio; Forlin, Corrado; Averini, Riccardo; Ganzaroli, Walter; Stoppele, Rino; Pattarozzi, Gaetano; Pennone, Luigi; Veronesi, Ugo (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| germanofilo e neutralista con la sua concezione di un’ italia mediocre supina sotto il passato e gli | ||
Buccafusca, Emilio; Forlin, Corrado; Averini, Riccardo; Ganzaroli, Walter; Stoppele, Rino; Pattarozzi, Gaetano; Pennone, Luigi; Veronesi, Ugo (1938) | ||
| vedi testo esteso | ||
| a colpi di abnegazione e col martellamento di un’ altra passione quella che ci fonde colla macchina | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1940) | ||
| vedi testo esteso | ||
un popolo che voleva morire in un’ assemblea antifascista di brusselle la lanterna sorda dove | ||
Filippo Tommaso Marinetti (1940) | ||
| vedi testo esteso | ||
| serbatoio di spunti lirici e d’ immagini eccitanti un’ attualità insomma adatta a rallegrare abolendo il sempre | ||
Marinetti, Filippo Tommaso (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| sì scatenando con la vittoria del proprietario negro un’ inesauribile e sconquassante allegria negra senza fine | ||
De Angelis, Rodolfo (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| attaccava il fosso di qua mentre di là un’ altra squadra la secondava così il lavoro | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| di quanto non si pensasse sarebbe stata un’ occasione favorevole per fargli dimenticare la storia del | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| tenuta lontana da ogni pericolo qui era un’ altra cosa il fascino maligno dell’ acqua | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| ferita a morte e fu come se un’ orrenda massa di dolore avesse fatto improvvisamente irruzione | ||
Govoni, Corrado (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| combattere la lentezza lo stanco il morbido con un’ arte che abbia la grazia elastica di una | ||
Maria Goretti (1941) | ||
| vedi testo esteso | ||
| nel loro recente manifesto che vuole e propugna un’ architettura senza più facciate verticali ma con terrazze | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Crali, Tullio; Bagnaresi, Francesco (1942) | ||
| vedi testo esteso | ||
| anarchici pensiero voce delle macchine organizzate un’ ampia compenetrazione di piani tempospazio lontanovicino odiocarltà concretastratto | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini); Giovanni Acquaviva; Aldo Giuntini; Luigi Scrivo (1943) | ||
| vedi testo esteso | ||
| della propria personalità la macchina stessa e di un’ altra parte il compito di battaglia l’ | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini); Giovanni Acquaviva; Aldo Giuntini; Luigi Scrivo (1943) | ||
| vedi testo esteso | ||
| l’ amore intensificandolo e armonizzandolo fino a farne un’ autentica nuova arte non come sognarono greci romani orientali | ||
Filippo Tommaso Marinetti; Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini); Giovanni Acquaviva; Aldo Giuntini; Luigi Scrivo (1943) | ||
| vedi testo esteso | ||
| novità e originalità è inesauribile ora con un’ acrobazia paradossale bisogna riportarsi alle origini e ascoltare | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Crali, Tullio (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| poesia a passaggi obbligati per la conquista di un’ atmosfera sinfonica e preludio alla polisinfonia delle parole in libertà | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Crali, Tullio (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| e rumoristi ed una intensità emotiva può sviluppare un’ atmosfera di sonorità poetiche la declamazione assurgerà | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Crali, Tullio (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||
| consentendo come un normale spartito entro certi limiti un’ esatta interpretazione 7 noi futuristi sentiamo | ||
Marinetti, Filippo Tommaso; Crali, Tullio (1944) | ||
| vedi testo esteso | ||